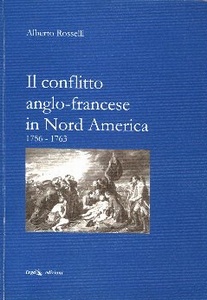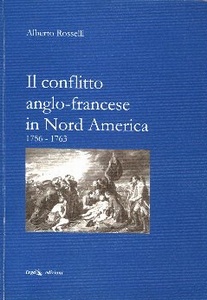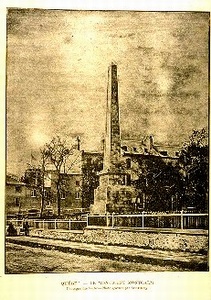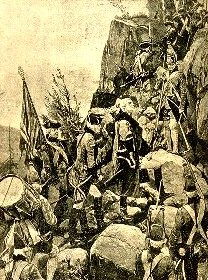"Nel 1756 ebbe inizio la prima vera campagna
franco-inglese in nord America: il primo conflitto della storia ingaggiato a
livello mondiale da due potenze europee. Oltre che sui campi del Vecchio e nuovo
Continente, inglesi e francesi si batterono per sette lunghi anni anche in
India, in Africa e con le rispettive flotte su quasi tutti gli oceani". Abituati
a studiare che il primo conflitto mondiale è deflagrato il 28 giugno 1918, si
rimane un po' spaesati di fronte ad un'affermazione così perentoria. Della quale
è padre il giornalista Alberto Rosselli, autore di un libro -
Il conflitto
anglo-francese in Nord America. 1756-1763 (Erga edizioni, Genova, 1999. pp.
222, L. 23.000) - che analizza un singolo quadrato dello scacchiere mondiale su
cui si combatte la celebre
Guerra dei Sette Anni. Un testo che, pur
sostenuto da una tesi da revisionismo allo stato puro, nulla concede a facili
strumentalizzazioni o sensazionalisti, ma si limita a raccontare un storia,
ricca di dati e di eventi. Meglio: più che una storia, la parentesi principale
di una vicenda più ampia: la
Guerra dei Sette anni, appunto, che dal
1756 al 1763 oppone Gran Bretagna e Prussia da un lato, Francia e Austria e
alleati minori dall'altro. Un conflitto che nasce a causa della rivalità
economica che intercorre fra il regno inglese e quello francese nelle rispettive
colonie dell'America del Nord e dell'India. Cui si aggiungono le rivendicazioni
austriache di Maria Teresa, smaniosa di rientrare in possesso della Slesia che,
dal 1740, è occupata da Federico II di Prussia. Lo scacchiere, quindi, è
piuttosto ampio. Una prima avvisaglia di ostilità si ha nel 1755, quando la Gran
Bretagna, senza dichiarare guerra, si impadronisce di numerosi mercantili
francesi nel corso di ordinarie navigazioni. E' il primo atto di
un'
escalation verso il conflitto che prosegue sui tavoli della
diplomazia.
Il 16 gennaio 1756 Federico II di Prussia si impegna, nei
confronti degli inglesi, a difendergli da ogni attacco che provenga dalla
Francia: è "l'accordo di Westminster". La Francia, da par suo, rinuncia alla
tradizionale alleanza con i prussiani e accetta le proposte dell'austriaco
Kaunitz: il 1 maggio dello stesso anno sigla a Versailles il trattato di
alleanza con l'Austria, che prevede reciproco aiuto in caso di guerra. Alla
coalizione franco austriaca si associano in seguito la Russia della zarina
Elisabetta, la Polonia di Augusto III e la Svezia. La
Guerra, in
prevalenza, si svolge in mare. Già nel maggio del '56, un corpo di spedizione
francese si impadronisce di Minorca, occupata dagli Inglesi. I quali, per
contro, operano il blocco delle coste francesi e riacquistano la supremazia
marina, grazie all'energica personalità del loro Primo Ministro, William Pitt.
E' opportuno chiedersi, a questo punto, quale sia la situazione in America del
Nord. Qui, le colonie inglesi, eccezion fatta per il Massachussets, appaiono
disinteressate a cercare un accordo che permetta loro di tenere una linea
politica unitaria.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
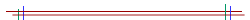 |
 |
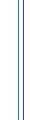 |
Le colonie
francesi
in America del Nord
sono governate da
capi militari
inviati
dalla madrepatria |
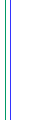 |
 |
 |
 |
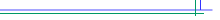 |
 |
Già
le difficili comunicazioni naturali con l'Inghilterra rendono ostico lo scontro
con i francesi; per di più, le stesse colonie alimentano l'una nei confronti
dell'altra focolai di rivalità. In esse aleggiano i germi di un individualismo
primitivo che non aveva mai conosciuto la rigidità di una disciplina imposta dal
sovrano o addirittura dai meccanismi gerarchici feudali. Ciò che invece accade
nelle colonie francesi. Queste, all'opposto, ignorano concetti quali libertà
dalla Chiesa o dallo Stato: le caratterizza invece un'indiscussa lealtà nei
confronti del Governo di Parigi.
Al di là delle differenze filosofiche e
politiche, ciò che acuisce la frizione tra Francia e Inghilterra in America del
Nord è anche la dislocazione territoriale delle colonie. Quelle francesi, come
grani di una corona, si distendono lungo una linea di comunicazioni fluviali che
va dal fiume San Lorenzo al Mississippi, e fanno da barriera alle migrazioni di
quegli inglesi che, come accadrà poi a tanti americani, si spingono verso ovest
alla ricerca di nuovi territori vergini, primo embrione di quella che passerà
alla storia come "l'epopea della frontiera". Queste colonie sono governate da
capi militari direttamente inviati dalla Francia. E, cosa importante, tengono
stretti contatti con le tribù degli indigeni, i
sauvages, che trattano
con riguardo ma che non esitano a impiegare senza scrupoli soprattutto delle
operazioni di guerra. Una tra queste è ricordata per la particolare violenza
delle operazioni: la battaglia del forte Duquesne. Nel 1753 i francesi cacciano
dalla valle dell'Ohio, che chiamano
la belle rivière, i commercianti
inglesi che la abitano ed vi erigono un forte chiamato
Duquesne, in
onore del generale che li guida. Due anni dopo, il generale inglese Braddock,
inviato dal governo di Newcastle con il compito di riconquistare la piazzaforte
perduta, viene massacrato con le sue truppe in un imboscata di francesi e
indiani. Formalmente però, s'è detto, la guerra comincia nel 1756. Per
l'Inghilterra, il conflitto rappresenta una scommessa. Una grave crisi politica
travolge i due tradizionali partiti, i Whigs e i Tories; situazione dalla quale
il Paese esce brillantemente grazie all'azione del già citato William Pitt. Il
primo ministro, infatti, risolve l'
impasse risvegliando nel suo popolo
una sorta di orgoglio che valica i confini della nazione per trasformarsi in
vera sete di Impero. Che è poi la stessa sete del Pitt, che per realizzare i
suoi disegni di espansione - riusciti benissimo: tra il 1758 e il '60
l'Inghilterra amplia notevolmente il suo dominio coloniale - ha necessità di
riaffermare la supremazia navale delle flotte di Sua Maestà. La Francia, a
riguardo, è un pericoloso ostacolo che va sconfitto soprattutto sul terreno
delle colonie, in particolare in Canada. Per garantire migliori e più sicuri
collegamenti, gli Inglesi adottano una tecnica speciale: trasportano oltreoceano
le truppe di terra e, una volta fatte sbarcare, le proteggono con i cannoni
della flotta. Gli eventi principali sono la presa di Louisbourg (1758), chiave
d'accesso per il controllo sul territorio del San Lorenzo e la scalata dei
Piani di Abraham, importante per poter arrivare alla conquista di della
città di Quebec, controllata dall'esercito regio francese. Conquista che è
l'evento centrale del libro di Rosselli. Due sono gli indiscussi protagonisti di
quella battaglia: il generale inglese Wolfe e il suo collega francese, il
Marchese di Montcalm. Personaggio, quest'ultimo, decisamente carismatico.
Proveniente da una ricca famiglia della nobiltà provinciale, ama la cultura
classica e sogna di diventare un accademico di Francia. Ma i genitori lo
costringono alla carriera militare, impegno tradizionale per i maschi della
casata. Nella cui carriera eccelle. A soli 9 anni è allievo ufficiale. In
seguito, scrive Rosselli, viene "ammirato per la sua intelligenza tattica e il
suo coraggio dai superiori ("Il suo innato sprezzo del pericolo lo portava a
esporsi sempre laddove il fuoco nemico era più violento") (…). Nel 1755 il
Ministro D'Argenson gli comunicò che il Re era intenzionato a nominarlo
comandante in capo delle truppe francesi in Nord America con il grado di
maggior-generale, cosa che si verificò all'inizio dell'anno seguente (…). Nel
corso della campagna nordamericana, nonostante l'esiguità dei mezzi militari e
degli uomini messi a sua disposizione, il generale riuscirà ad ad ottenere
brillanti successi ai danni di un nemico di molto superiore.
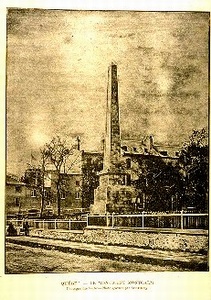 |
Il monumento
al generale
Montcalm eretto a Quebec |
Nei
primi due anni del suo comando in quel lontano scacchiere, Montcalm batterà più
volte gli angloamericani in scontri importanti come quelli di Fort William
Henry, Oswego, Fort Carillon, Toconderoga, Beauport e sulle rive del Lago
Ontario, non riuscendo però ad evitare la caduta dell'impero francese in Nord
America". Caduta che, volendo attribuirne il valore simbolico alla presa di
Quebec da parte degli Inglesi, avviene il 13 settembre 1759. Prima di allora, la
città presidiata dai Francesi è sottoposta a tre mesi di assedio e
bombardamenti. La situazione militare, fino a quel momento, è equilibrata in
entrambi gli schieramenti. Un equilibrio, tuttavia, dovuto in prevalenza a
fattori negativi. Per quanto riguarda le colonie inglesi, il già citato
individualismo politico che le pervade va a investire anche il profilo militare:
ognuna di esse respinge infatti autonomamente le scorrerie delle armate francesi
e dei drappelli di indiani che periodicamente le investono. L'unico elemento che
le accomuna è una decisa diffidenza nei confronti del governo di Londra. Per di
più, all'interno della coalizione non mancano i diverbi con i coloni americani.
Scrive Rosselli che costoro, "inquadrati nella Milizia, mal sopportavano
l'arroganza, il distacco quasi aristocratico e la ferrea disciplina ostentati
dagli ufficiali inglesi, senza considerare che gli americani erano disposti a
combattere contro i francesi e gli indiani alleati in primo luogo per difendere
i loro stessi ideali di libertà, quelli che avevano spinto i predecessori ad
attraversare l'Oceano. Pur rimanendo sostanzialmente fedeli alla corona
britannica, i coloni ambivano a qualcosa di più". E cioè il riconoscimento da
parte di Londra della dignità di cittadini, non più sopportando il ruolo di
sudditi. Per ottenere tanto, gli americani sanno di doversi guadagnare sul campo
i galloni del prestigio militare nei confronti della Corona. Benjamin Franklin e
George Washington, futuri padri della Patria americana, che al tempo combattono
accanto alle truppe inglesi, sono tra i primi a voler cercare necessariamente
un'intesa con gli alti comandi militari. Intesa di cui gli stessi inglesi,
considerata la mancanza di coesione tra le loro colonie, hanno disperatamente
bisogno.
Sul versante francese la situazione non è troppo differente. La
coesione, qui, manca tra il governo di Versailles di Luigi XV, e i comandi
militari dislocati nel nuovo mondo. La Francia preferisce infatti concentrarsi
sullo scacchiere europeo, dove la guerra sembra andare bene (gli alleati
austriaci, nel giugno '57, hanno sconfitto a Kolin le armate di Federico II di
Prussia). Per di più, a Versailles, dallo stesso anno cambiamenti al vertice
amministrativo contribuiscono ad aumentare l'indifferenza della corona per le
sorti militari nella
Nouvelle France. In pochi anni mutano tre ministri
(da Machault si passa a Moras, quindi a Massiac e a Berryer), ma non la politica
di assottigliamento di risorse civili e militari che condurrà l'impero francese
alla rovina. Il generale Montcalm si vede quindi indotto a ritirarsi su
posizioni strettamente difensive, per salvare il salvabile: concentra il grosso
delle truppe a Nord, lungo i fiumi San Lorenzo e Richelieu, e lascia abbandonate
al loro destino le zone coloniali dell'Ohio e della Lousiana. Decisione
drammatica, dettata da un forte bisogno di scorte che, qualora fossero state
destinate a queste ultime due zone, avrebbe impedito la difesa del territorio
canadese. "Montcalm cercava, in buona sostanza - scrive Rosselli -, di
aggrapparsi a quella parte dell'impero ch'egli riteneva ancora difendibile fino
alla firma di un armistizio o di una pace con l'Inghilterra". Ma nella primavera
del 1759, il Primo Ministro Pitt nomina James Wolfe comandante delle forze
terrestri destinate ad espugnare Quebec. Le alte sfere militari del governo di
Londra non approvano la scelta: Wolfe è giovane (ha solo 32 anni), inesperto e
troppo impulsivo. Un ottimo ufficiale, ma non certo un comandante cui affidare
un'operazione tanto complessa da comportare il più alto spiegamento di uomini e
mezzi mai attuato nel corso dell'intero conflitto. Necessario, dopotutto, per la
struttura stessa della città di Quebec, tra le poche città francesi
d'oltreoceano dotate di cinta muraria.
"Sin dall'anno della sua fondazione
(1606) - racconta l'autore del libro
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
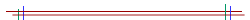 |
 |
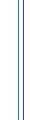 |
Nella battaglia
di
Quebec gioca
un importante ruolo
la componente
psicologica umana
|
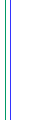 |
 |
 |
 |
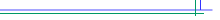 |
 |
-,
i francesi avevano provveduto in fasi diverse a cingerne l'abitato con bastioni
ed opere passive erette soprattutto a protezione della zona antistante il fiume
(San Lorenzo, ndr)". Inoltre, sulle prime, la situazione tra i francesi era
apparentemente positiva: l'armamento individuale di reparto è buono, malgrado
l'insufficienza di munizioni; e il morale è decisamente alto. Vi contribuiscono
soprattutto i miliziani canadesi, decisi a difendere la loro unica e vera patria
sino all'ultimo colpo di moschetto. I problemi, quindi sembrano essere tutti
inglesi: Wolfe, bloccato con la sua flotta davanti alla città di Quebec, non ha
ancora elaborato un piano per espugnarla. Inoltre, le milizie dell'altro
generale inglese, Amherst, pronte ad andare ad ingrossare le fila dello
schieramenti di Wolfe, vengono bloccate da incursioni di milizie scelte
franco-canadesi. Nella battaglia di Quebec, tuttavia, gioca un importante ruolo
la componente psicologica umana, capace, come vedremo, di far realizzare agli
inglesi un grande risultato in una modesta vittoria e ai francesi di subire una
tragica sorte in una altrettanto modesta sconfitta. Ma veniamo ai fatti, narrati
da Rosselli con il piglio del cronista inviato sul campo. "Verso le 8 del
mattino del 13 settembre 1759 - attacca -, i 4.400 soldati inglesi agli ordini
del generale James Wolfe e del vice comandante Townshend erano disposti in
ordine di combattimento sui
Piani di Abraham". Di fronte a loro, un
ostacolo solido e ben difeso: la città di Quebec, cinta dalla sua mura. Poca la
forza offensiva degli inglesi: solo un paio di cannoni da campagna di piccolo
calibro, utili per il tiro ravvicinato. Montcalm, osservata la posizione del
nemico, comunica ai suoi ufficiali di voler attaccare subito gli inglesi, per
prevenire il loro ulteriore rafforzamento. Ramezay, altro generale francese,
suggerisce di attendere l'arrivo di altri 3.000 soldati, guidati dal
Bougainville. Il generale conta però sull'arrivo di altre truppe alleate,
comandate dal governatore Vaudreuil, non distanti dalla città, e non presta
orecchio ai consigli di Ramezay. Il sostegno di Vadreuil si rivela però fondato
su un colossale equivoco: un telegramma che annuncia a Montcalm "Nous verrons
cela", noi verremo lì, senza però precisare altro riguardo il giorno e l'ora
prevista per il congiungimento di truppe. Cosa che fa credere a Montcalm di
poter disporre di un credito di forze che si rivelerà poi inesistente. Alle 9
del mattino, il generale sferra l'attacco: "Il generale francese - scrive
Rosselli - abbandonò per la prima volta la sua abituale prudenza per buttarsi in
un'azione avventata e apparentemente incomprensibile". Alla testa del
contingente c'è Montcalm in prima persona.
Wolfe, di fronte a tanto ardire,
non ha altra scelta se non quella di rispondere, anche per evitare di trovarsi
assediato alle spalle dalle truppe del citato Bougainville. I francesi, nel giro
di un'ora, sono sui
Piani di Abraham di fronte al nemico. Montcalm, nel
frattempo, ordina ad una staffetta di rientrare a Quebec per chiedere a Ramezay
25 cannoni da campagna. Ne arrivano solo 3: Ramezay stesso, forse irritato per
la sordità del generale ai suoi precedenti consigli, si giustifica dicendo che
il resto del materiale gli è indispensabile per la difesa della piazzaforte.
Alle 10 del mattino, 3.500 soldati francesi avanzano su più verso 4.000 inglesi.
"Sulla brughiera, già intaccata e rinsecchita dal precoce autunno canadese -
scrive Rosselli - si stagliavano i due schieramenti policromi. Quello di Wolfe,
formato da più linee di giubbe rosse appartenenti alle truppe regolari, e quello
franco-canadese, più vario, composto da linee azzurre, blu e bianche (le divise
dei fanti dell'Esercito e della Marina) e da quelle, tinta terra, appartenenti
alla milizia canadese. Sparsi tra i reparti della milizia, alcuni manipoli di
indiani a torso nudo rammentavano che i due più famosi esercito europei si
stavano fronteggiando in una terra lontana e selvaggia". Giunti gli schieramenti
a tiro di moschetto, Montcalm, che dall'alto di un cavallo nero dirige i
movimenti dei suoi, ordina di attaccare - baionetta in canna e stendardi al
vento - le tre
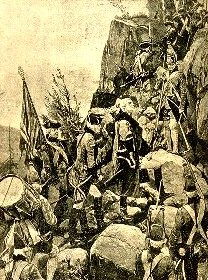 |
Il generale
inglese Wolfe durante
la battaglia di
Abraham |
linee centrali dello schieramento
inglese. E' una bolgia: i fanti francesi, lanciando ardite grida di guerra,
corrono brandendo le armi in pugno. I tamburini, fino ad allora precisi nello
scandire il ritmo dell'avanzata, vengono travolti dalla furia dell'attacco. Che
però si rivela disordinata: i canadesi, buttandosi ventre a terra per evitare il
fuoco nemico, rompono la compattezza del fronte, e la manovra non ha esito
soddisfacente. Anzi, finisce decisamente male. I fucilieri di Wolfe scaricano
sui francesi una grandine di piombo che li costringe alla fuga. Per risultare
più efficaci, caricano il loro fucile con due palle di piombo, che fracassano il
petto e la testa dei soldati di Montcalm. Un ufficiale inglese, al termine della
battaglia, parlerà della "più efficace scarica di moschetti mai eseguita su un
campo di battaglia". Gli inglesi avanzano tra urla e spari, e la ritirata
francese si trasforma in rotta. Alcuni tra questi soldati, però riescono a
scatenare un maligno fuoco di retroguardia, del quale vittima proprio il
generale Wolfe. La ferita è mortale: colpito al polso, al petto e al torace, e
con un polmone trafitto, il generale muore, a detta dei suoi soldati, senza
riprendere conoscenza. Alcuni storici inglesi, fa notare Rosselli, scrivono
invece che prima di morire il giovane condottiero pronuncia parole quali "La
vittoria sembra ormai sicura. Meno male. Ora, Iddio sia lodato, potrò andarmene
in pace".
Ma in quel tragico scontro, è ferito mortalmente anche il generale
Montcalm. Centrato a una coscia e al ventre, cade da cavallo e viene soccorso
dai suoi ufficiali. Il giorno successivo, un medico tenta inutilmente di
curargli la ferita. La morte di Montcalm ha un'eco devastante tra le fila
francesi, e ingigantisce quella che per gli inglesi è una grande vittoria
tattica, ma non strategica. I francesi devono abbandonare il terreno e perdono
più di un terzo degli effettivi, comandante compreso. Quebec, inoltre, è
completamente circondata. Il contingente francese, però, può ancora disporre
delle armate di Bougainville e di Vaudreuil, che allo scontro non hanno
partecipato. A mezzogiorno, le truppe del secondo generale arrivano a nei pressi
di Quebec. Vaudreuil cerca di galvanizzarle, di incitarle allo scontro, ma è
tutto inutile. L'effetto psicologico della sconfitta e della morte di Montcalm
si ripercuote sulle truppe, sconfortandole e privandole di aggressività. Solo
1.000 soldati, per lo più canadesi in un ultimo impeto di orgoglio patrio, si
lanciano in un confuso e inutile attacco verso i miliziani inglesi. "Il silenzio
era calato sui Piani di Abraham - scrive Rosselli -. La brughiera era
disseminata di soldati uccisi e di armi abbandonate. Quella che si sarebbe
rivelata la più importante battaglia dell'intero conflitto nordamericano era
durata poco più di un'ora. Lo scontro era stato breve ma sanguinoso. I franco
canadesi avevano subito perdite severe: 1.200 fra ufficiali e soldati, uccisi o
feriti. Gli inglesi avevano invece perso 660 uomini". Circondata dalle armate
inglesi e stretta in un assedio che dura ormai da tre mesi, Quebec si arrende.
Il 18 settembre 1759, tre compagnie di granatieri inglesi occupano le porte
della città e innalzano il vessillo britannico. Dominata dal caso e dalle
oscurità della psicologia umana più che dal mestiere delle armi, si conclude
così la più importante battaglia dello scacchiere americano nella
Guerra dei
Sette anni, chiave di volta per le sorti infauste dell'impero francese.